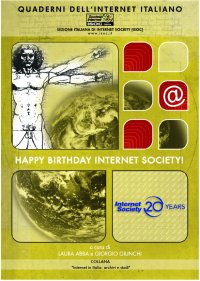- L'Internet
costituisce un servizio generico per eccellenza: interconnessione neutrale
d'informazione automatica.
- A livello
universale ovviamente: l'Internet non ha confini, per definizione.
- Un elementare
corollario di cronaca e storia, e storiografia, è che un "Contributo
italiano alla evoluzione dell'Internet" è una moneta composta
da due facce fisiologicamente intrecciate: l'insediamento locale dei nodi
strutturali di rete, e il loro rispettivo cordinamento internazionale.
- In pratica:
dagli anni '80, in tutto il mondo, con tempi e ritmi nazionali diversi,
le comunità d'avanguardia dell'università e della ricerca
hanno agganciato, importato, distribuito localmente, testato vari prototipi
di rete a fini di servizi fondamentali: distribuzione di calcolo, trasferimento
di files e posta elettronica.
- All'epoca
concorrevano a diventare standard:
- alcune
reti proprietarie [con in testa DECNET della Digital e SNA della IBM];
- una rete
istituzionale politicamente appoggiata dalle istituzioni europee [X25 OSI];
- e una
più duttile rete aperta e neutrale statunitense, non proprietaria
proprio per vincolo originario di progetto della sua matrice accademico
militare [ARPANET]: lo stack protocollare TCP/IP.
- Dall'inizio
degli anni '90 i contatori di rete evidenziano una verità molto
semplice: "tutti vogliono TCP/IP".
- L'aspetto
che ci interessa documentare in questo Quaderno è il processo per
cui l'Italia fu una delle prime sponde transatlantiche continentali e globali
di una internazionalizzazione egemonica dell'Internet così come
la conosciamo, cioè nella sua vincente versione neutrale.
- Casi di
scuola del contributo italiano alla evoluzione dell'Internet furono una
tempestiva interfaccia CNUCE alll'ARPANET e in sequenza l'accreditamento
che IANA riconobbe il 23 dicembre 1987 [una delle prime delegazioni europee],
sempre al CNR-CNUCE, per la gestione del ccTLD .it.
- Il filo
logico del capitolo parte dalle disseminazioni italiane originarie di tale
inter-net-working e documenta gli sviluppi nazionali e i coordinamenti
internazionali dei suoi nodi strutturali:
- Reti della
Ricerca,
- Registri
dei Nomi a Dominio,
- Uffici
di Regola e Protocollo,
- Internet
Exchange degli operatori.
- Il capitolo
si risolve nel progressivo trasferimento di know how dalle reti accademiche
e della ricerca a quelle civili e infine business: agli albori dell'Internet
di massa, quando Internet "sfonda nel mercato" e pervade quindi
gli standard esistenziali delle comunità e delle persone.
|
![]()
![]()
![]()